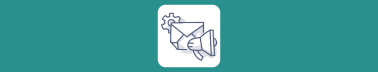Elon Musk e la navigazione a vista - Libertà
L'Uccellino Celeste si è trasformato in X, ma le gatte da pelare non mancano.
Più scorre il tempo, gli anni i mesi e i giorni si allontanano dal Web degli albori, e più ci accorgiamo che le sensazioni di stretta delle istituzioni sulle app di messaggistica e sui social network sono più che sensazioni. Norme stringenti si fanno avanti, ora come lame taglienti che affondano nel burro tiepido del laissez faire dei patron e ora attraverso intimidazioni ad essi.
Quest’oggi vorrei affrontare brevemente un altro caso, dopo quello di Durov e il suo Telegram: quello di Musk e il suo X. Ma quale fra i molti? Il più recente e “fragrante”, che ha visto Thierry Breton, il commissario al Mercato Interno, nell’Unione Europea, addirittura diffidare preventivamente l’effervescente imprenditore sui contenuti dell’intervista a Donald Trump, in programma sul social che era dei cinguettii dell’uccellino celeste. Non solo: l’europarlamentare, molto vicino a Macron, Sandro Gozi ha minacciato di smantellare X in Europa “se Elon Musk non si adegua alle regole Europee sui servizi digitali.”
Ora: chi stabilisce che l’ex Twitter non sta rispettando le regole? Un europarlamentare a cui va bene passino le notizie che dipingono Zelens'kyj come San Francesco e Putin come il lupo da addomesticare, ma le altre di segno opposto no?
Forse che non sono stabiliti dei parametri univoci, chiari e fermi, che dovrebbero proteggere l’utente dalle fake news?
Teoricamente esistono, ma appositamente i politici interessati, quelli della linea dominante su una specifica area del Pianeta e in uno specifico periodo, trasformano l’asetticità delle norme (ove esistano) in arbitrarietà necessaria per tirar l’acqua al proprio mulino, se serve mettendo alla berlina, o ai ferri, gli amministratori responsabili delle società informatiche che offrono una piattaforma generalista finalizzata al collegamento fra individui in giro per il mondo.
A questo proposito, metterei in evidenza come perfino un gruppo che non gode di molta simpatia fra i suoi stessi utenti (Meta, ex Facebook) ora appaia come il burro tiepido, a cui ho fatto sopra cenno, attraversato da una lama tagliente, ma si è opposto, a suo tempo, come ha potuto, a pressioni importanti. Senza voler e potere entrare nel merito delle ragioni occorse, ricorderei come, nel 2016, il vice di Zuckerberg, Diego Dzodan, fu arrestato in Brasile poiché la magistratura, a richiesta, non otteneva informazioni sul traffico WhatsApp.
Il problema degli interventi di Stato (e, basti pensare all’Unione Europea, anche sovranazionali) riguarda altresì pure il rispetto della riservatezza nelle comunicazioni individuali o all’interno di gruppi ristretti (definizione, ahimè, vaga, ma che intende offrire l’idea di ciò che viene scambiato fra persone che si conoscono abbastanza bene; definizione che, sono il primo a riconoscere, meriterebbe una misura precisa di fronte a una qualunque necessità di normazione).
Se fosse sempre primario interesse delle istituzioni aver conoscenza di quanto scorso nelle chat per ricostruire qualche reato, saremmo tutti ben felici, ma qualche dubbio insorge nel momento in cui osserviamo, ad esempio, che un presidente di Senato potrebbe ritardare, o addirittura impedire, la ricerca della verità attorno a una violenza sessuale, forse dal figlio perpetrata, adducendo ragion di Stato, e dunque invocando riservatezza, riguardo a quanto conservato in uno smartphone e attraverso di esso trasmesso o ricevuto, sebbene detto cellulare avanzato fosse nella disponibilità del figlio di cui sopra.
Come se ne esce? Non se ne può uscire sicuramente pensando di affidare, tale contrasto alla censura, a nuovi politici. L’unica speranza per rivivere una discreta libertà di circolazione delle informazioni non può che risiedere nella presa di coscienza di quanti più utenti possibili.
“Dovrebbero”, dunque dovremmo.
Riuscire a riconoscere quest’esigenza, penso rappresenti già un passo rilevante.