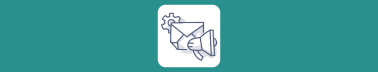Lo scrittore Pino Aprile fa subito un paio di considerazioni. La prima riguarda la provenienza dei morti uccisi per mafia nella difesa dei principi della civiltà, oltre che del diritto. Escludendo il procuratore Bruno Caccia, il generale Dalla Chiesa e pochi altri, osserva come i restanti orgogliosi servitori fossero meridionali. La seconda riguarda l'atteggiamento costruttivo del fare rete (ripreso continuamente nel testo) a Sud da parte di tanti cittadini, specialmente di giovane età.
Ci sono svariati pezzi di racconto nel libro (vicini fra loro), ai quali, il più delle volte, è difficile dare un collegamento reciproco. Non per questo sono poco interessanti. Si parla del politico cuneese Guido Crosetto e della sua paura di andare in Calabria, "la parte più brutta dell'Italia", poiché lì non sa chi potrebbe incontrare. Questo, per poi chiamare la mafia calabrese camorra. Questo ancora mentre, nel capoluogo della sua regione, il Piemonte, tutte le mafie raccolgono voti per partiti politici. Questo mentre i primi comuni a costituirsi parte civile contro la mafia sono stati calabresi. Questo mentre il più grosso processo contro la mafia, più grosso anche del maxi processo di Falcone e Borsellino e del processo Spartacus contro la camorra, è stato calabrese (purtroppo l'autore non ne specifica la denominazione e non è semplicissimo determinare con certezza a quale faccia riferimento).
Sia Salvemini che Joe Bonanno hanno affermato lo Stato usa la mafia per tenere sotto controllo le genti del Sud. Ci sono organi che vengono definiti "deviati" in una loro parte solo (guarda caso) quando vengono scoperti.
Gianfranco Miglio, il cd. ideologo della Lega Nord, affermò: Arrivo in Toscana e sento odore di cous-cous.
Questi e altri racconti, brevi o lunghi, spesso servono a far capire che non bisogna vergognarsi. Almeno non sono i meridionali a doverlo fare. C'è, piuttosto, da venire allo scoperto.
L'autore, ancora, teorizza una specifica capacità femminile di far uscire le famiglie dai problemi di malavita organizzata e coglie l'occasione per mettere particolare rilievo a un'affermazione di don Ciotti, secondo cui saranno le donne a vincere la mafia.
Uno dei più interessanti aneddoti riguarda una signora di Ercolano, proprietaria di tre negozi d'abbigliamento sottoposti a richiesta di pizzo. Una lunga battaglia l'ha vista vincente e il suo coraggio sarebbe da prendere a esempio. Il secondo, ma non in ordine d'importanza, riguarda l'acciaieria ILVA di Taranto, che così tante morti e malattie ha cagionato. Inizialmente la popolazione locale vide la struttura industriale che stava per impiantarsi come una manna contro la disoccupazione. Ben presto il latte delle mamme, non solo di essere umano, si avvelenò e tracce di scarti industriali furono trovati in molte parti del corpo degli abitanti. Si corruppero sindacalisti e si declassarono dipendenti combattivi che chiedevano altre condizioni di lavoro, senza che fosse loro risparmiato un forte stress psicologico dovuto al confinamento presso una palazzina, chiamata "Lef", all'interno della quale sarebbero dovuti stare con le mani in mano. Un terzo riguarda Tempa Rossa, un sito petrolifero lucano che altri danni ha provocato e per il quale è stato fatto passare il progetto, dall'on. Stefania Prestigiacomo, benché privo della necessaria Valutazione del Rischio di Incidente Rilevante. Un quarto punto, un racconto ancora a più sfaccettature, riguarda le difficoltà di associazioni e cooperative campane di lasciarsi affidare la gestione di luoghi abbandonati e disponibili. Ricorda al proposito, riferendosi a un caso di edificio lasciato alla mercé di chiunque, come, quando resosi disponibile, l'allora sindaco Rosa Russo Jervolino neppure si preoccupò di rispondere a chi l'avesse interessata (la cooperativa NCO, Nuova Cucina Organizzata) per un suo uso.
Passa, poi, da Scampia il riscatto di Napoli, specie attraverso lo sport, con un centro ben organizzato che rappresenta pure un punto di aggregazione e confronto. Ciò grazie a cittadini volenterosi che (l'autore sempre ricorda) fanno rete, si annettono in gruppi più o meno grandi che si uniscono ad altri gruppi di varia estensione. Però, tristemente, ricorda pure come il sottosegretario Nicola Cosentino è potuto finire in galera solo dopo aver perso l'immunità parlamentare. Il fatto, chiaramente, offre molto alla riflessione. D'altronde non ci si può stupire, malgrado la vergogna, se si pensa che, con l'Unità d'Italia, i camorristi furono promossi ad ispettori di Polizia. Politici, a gran voce, chiedono di denunciare, ma è opportuno un cambiamento anche nelle Forze dell'Ordine, che dovrebbero in modo compiuto prendere coscienza del proprio ruolo. Si ricorda (evidentemente a solo titolo esemplificativo) il caso di un contadino che andò a denunciare e fu, dai carabinieri a cui si rivolse, sconsigliato.
Arrivano interrogativi. L'autore si chiede se i settentrionali, messi in certe condizioni, non avrebbero la stessa paura dei meridionali e perché si debbano, quasi in via esclusiva, studiare letterati del Nord. Questo mentre al Sud si muore anche per difendere il proprio diritto a respirare aria pura.
Vengono raccontate diverse storie, anche interessanti, ma spesso ci si domanda chi sia il soggetto che le "vede". Inoltre, benché l'intero testo sia a regalare uno scossone a chi ha il Sud dentro, tenendo in considerazione specifici argomenti (l'inquinamento, la corruzione, le estorsioni ecc.), non si osservano buoni collegamenti tra i fatti nudi e puri né conformità nei messaggi che vengono lanciati. Ad alcune storie è stato riservato un discreto spazio e ad altre uno insufficiente. Quella, probabilmente, meglio raccontata è relativa all'impianto ILVA di Taranto, dalla benedizione iniziale degli abitanti alla maledizione finale degli stessi.