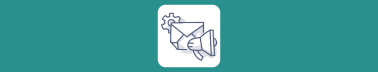Ho scelto questo libro un giorno, nella biblioteca comunale, desiderando farmi attrarre solo dalla copertina e decidendo di buttarmi su un autore a me sconosciuto. In più scartando qualche titolo che non mi stava colpendo.
È stato così che ho scelto L’editor.
Vi dico subito che è un giallo, ambientato per lo più a Roma, con una toccatina in luoghi che separano la città di Romolo e Remo da Milano e a Strasburgo, e ancor più marginalmente in un sud Italia poco definito. Il protagonista è un ispettore di Polizia, mandato nella Capitale a operare, pur essendosi dimostrato sufficientemente abile in quel sud poco definito di cui sopra, poiché autore di uno sbaglio, chiamiamolo così, durante la carriera.
C’è un brutale (nel senso di «spettacolare», poiché un omicidio di per sé è già un atto, eufemisticamente, poco dolce) assassinio, quindi c’è una vittima, ci sono vari soggetti intorno fra i quali l’investigatore deve destreggiarsi, e c’è una moglie dell’investigatore stesso a latere.
L’architettura degli eventi è interessante e i fatti giungono, man mano, davanti a questo poliziotto come i pezzi di un domino che si toccano e costringono a un movimento fluido conducente in scioltezza alla risoluzione del caso. Già abbastanza in là con gli anni, l’ispettore riuscirà a far su di esso luce una volta in pensione.
Se l’architettura è buona e la scrittura fluida, gli eventi sono piatti, i personaggi scarichi e gli ambienti grigi. Quel che accade potrebbe anche volutamente cercar di portare a immagini ombrose e tetri voli fantastici, ma il problema è, per me, una decisa mancanza non solo di pathos, quanto persino di dinamicità e senso delle concatenazioni. Per esempio, vi si trova un rapporto che possiamo definire <<amoroso>> (forse esagerando, ma definiamolo pur così) nato con le stesse probabilità con cui potrebbe nascere un fidanzamento fermando una donna o un uomo sul marciapiede e direttamente dichiarandosi.
L’ispettore non ha carattere, né lo si potrebbe considerare (tanto per dire) un individuo goffo, tuttavia fortunato nel suo mestiere, o magari maledettamente truce e sincero. Insomma, è come se non avesse un’anima e fosse costantemente mosso come marionetta dal proprio ideatore. Farà ossessivamente ricorso a sigarette di una certa marca (non vi dico quale solo per lasciarvi, eventualmente, il piacere di scoprirla), ma non v’è motivo sopra che sospinga a ragionare su tale comportamento e i dettagli per l’intera lettura, devo ammettere abilmente descritti, sono troppi, quasi sempre inutili; nulla spostano, nulla modificano in ciò che conta, proprio nulla, e, ancor di più, nulla producono in aspettative.
Sentire riconoscere merito a far parte del testo due artisti come Burri e Fontana, come forse con l’intenzione di rafforzare un senso enigmatico della storia, lo trovo poco utile e, peggio, di svantaggio se l’intenzione era quella di “sigillare” con ceralacca la monotonia (che non ha bisogno di sostegno) delle scene.
Simpatica, in tutto questo grigiore, ho trovato, invece, la dilettevole usanza di spedire lettere anonime a persone con fastidiosi difetti caratteriali che mai avrebbero accettato di esser trasparentemente ripresi.
Una riflessione mi è venuta nell’immaginare i cambiamenti dei luoghi, come già autonomamente mi era capitato (e mi capita) di fare, pensando, ad esempio, a combattenti caduti in battaglia dove cammino: specificamente, l’investigatore in un certo frangente si ritrova in un luogo dove prima era depositato il suo stesso sangue a terra, e di esso non vi era più traccia, e un’acacia svettava florida, ma al suo posto si osservava soltanto ormai un tronco amputato (presumibilmente appartenente allo stesso albero). È stato un flash e un richiamo insieme, ripeto, a ciò che mi capita di congetturare.
Non mi sento di suggerire la lettura del libro.